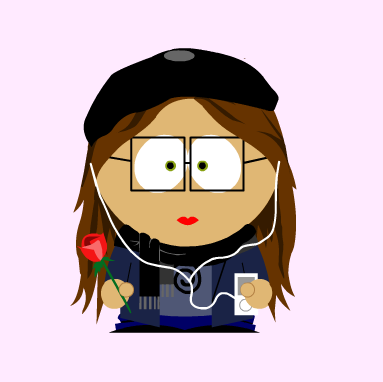martedì 16 novembre 2010
lunedì 1 novembre 2010
Primo Novembre

Primo novembre.
Sto suonando da ore.
Ore e ore e ore e ore seduta al seggiolino del pianoforte dello studio, battendo, sbattendo forte i tasti con le mie dita lunghe e allenate dallo studio, ma niente. Neanche stavolta.
Anche se, incatenata a sedere, continuo la mia esecuzione, lo scoraggiamento inizia a spandersi dentro me, come ogni volta, come ogni anno. Lo si vede: nero, questo sentire crudele e ostinato che scende piano nel corpo, come un fungo di inchiostro in un bicchiere d'acqua.
Ma avanti sempre. Mi sentiranno. Note su note, cascate di note, fiumi che debordano di note, alluvioni di note con bombardamenti di pedale, le braccia indurite, le dita esauste.
Poi, la porta si apre!, e mio padre entra nella stanza, gli occhi chini su un foglio di carta, passo lento assorto nei suoi pensieri.
Un esplosione di calore freddo nel petto e nella pancia!, perdo il fiato, e con un sussulto continuo il mio suonare, dimenticando la stanchezza: bombardo la tastiera di accordi, facendo scoppiare quell'illusione felice che mi cresce di nuovo, veloce, e risuona sui tasti la risata che mi esplode in bocca, in scivoli di scale cromatiche, e virtuosismi sciocchi per quella speranza felice che è tornata, mi risucchia l'ingannevole esultanza della possibilità
passi fino allo scaffale,
fruga nei cassetti alla ricerca di qualcosa, occhi fissi nel materiale
Non ti sente, non ti sente, non ti sentirà: lo scoraggiamento continua la sua opera
E la risata si inizia a spegnere, rapita dalla consapevolezza, ma la forzo: diventa meccanica; la rassegnazione striscia subdola a rimpiazzare la gioia. Cerco di proteggerla, nucleo di forza che ancora brilla, assalito dal nero carbone nero; l'aspettativa silenziosa si spegne, ma io continuo, continuo, testarda, e cerco di spegnere il dubbio, cerco di negare l'evidenza, contrastando il nero che si sparge dentro di me, combattendo una battaglia vana, uno scontro selvaggio e disperato, con la furia di chi sa che ne uscirà sconfitto
Senza tregua, sbagli, errori, la musica non si arresta, non si placa, perde il tempo, selvaggia e disperata, incessante nella fuga dalla realtà, spietata realtà, la melodia soffre e strilla di questa tortura brutale, ma non l'ascolto, e continuo, continuo, continuo, continuo
Si gira un attimo, distratto, verso il pianoforte nell'angolo.
Luce spenta da tanto su quella tastiera muta e impolverata. I libri ancora lì, mummificati nel tempo che passa. Uno era nuovo; è ancora chiuso, intatto. Il seggiolino su cui nessuno si siede, da allora.
È passato tanto tempo.
Un sospiro, poi gli occhi tornano nei cassetti
E la speranza si tramuta in un urlo, sopraffatta dall'angoscia
le dita, bianche, cercano ancora la tastiera d'avorio, scomparendo centimetro dopo centimetro, i polsi, le braccia
Non c'è più niente alla tastiera.
Passi lenti, la porta si richiude.
Silenzio.
domenica 24 ottobre 2010
Dieci di sera, strada
Asfalto. Linea continua, linea spezzata.
Limpida trasparenza di luna a inondare l'aria.
Dieci di sera, sulla strada.
Pedala, pedala, pedala sulla bicicletta bianca, vecchia bicicletta un tempo della mamma. Sciarpa annodata che copre il naso, naso freddo d'autunno.
La ruota scorre, nero nel nero, asfalto nella notte, copertone nell'asfalto, nero nella mente e nel petto, nero che si scioglie in catrame, in sangue che non scorre, pietrificata in una tristezza di pesante depressione.
La mente scivola, i pensieri si mangiano la coda, risuonano nella mente ululando.
Gli occhi scappano sulla strada; rapidi fuggono alla luna, bevono la luce che si specchia nelle pupille.
“signora luna, che mi accompagni, per tutto il mondo”
voce sommessa e fiato spezzato dalla corsa
“puoi tu spiegare, qual'è la strada, che porta a me”
risuona debolmente nella strada deserta, rimbalzando sugli specchietti delle automobili ferme al buio dei lampioni spenti
“non me ne venga, signora luna, se non ho amato”
memoria che vacilla, la canzone serpeggia tra i versi disordinatamente
e poi ricomincia
“signora luna, che mi accompagni, per tutto il mondo”
rauca e bassa
la luce è riflessa dall'acciaio del manubrio. Pare un fantasma scuro, perso nella periferia della città, circondata da quella strana luce notturna, un'aura debole attorno a lei.
Pedala pedala pedala
la luna nascosta dietro un albero, il buio. Splendore spento.
due fari senza precedenza, veloci, troppo veloci
Asfalto.
domenica 17 ottobre 2010
La Leggenda

Il silenzio. Mancano solo i grilli e la palla di paglia che rotola e sarebbe una scena da cartone animato: la classe è ammutolita.
Ha guardato per venti minuti buoni quella professoressa nel suo contorcersi in una dimostrazione articolata in mille angoli e trabocchetti, e, giurano tutti, hanno pure provato a capire.
Ma, lo giurano altrettanto, per loro quella roba là è arabo antico. Aggiungerei che è di qualche dialetto delle montagne, il dialetto. Pronuncia stretta.
La campanella suona dopo un minuto di silenzio -lutto e dovuto rispetto ai neuroni ormai fusi dei venticinque ragazzi-.
-Bene, allora dopodomani verifica. Arrivederci.- e prima che qualcuno, anche la peggior lecchina, potesse aprir bocca, scompare fuori dalla porta.
Trauma.
La classe è ridotta ad un acquario: ventidue pesci muti e immobili scrutano i vetri delle finestre pensando a quanto bene si starebbe là fuori. Un secondo dopo si sta per marciare sul piede di guerra: "quella stronza!" "non ho capito niente" crisi di panico e urletti isterici, chi digita in fretta un sms alla mamma "chiama il prof di ripetizioni, mà, che ho verifica di mate dopodomani", chi, ancora perso, fissa la lavagna, quasi sperando che il problema si sciolga, quel nodo di circonferenza si slacci e liberi la soluzione -e fatemi capire questa dannata materia, è matematica, non astronomia applicata!- e nessuno si accorge di lui.
Entra, e in un bisbiglio saluta la classe.
Posa cartella e soprabito sulla cattedra, siede, firma il registro, si guarda intorno -il caos continua-, allora batte leggermente la penna sul tavolo.
La classe tace.
"Buongiorno. Oggi manca il vostro professore, avete due ore di supplenza con me -si volta alla lavagna- Avete fatto matematica?"
Un mugolio sommesso conferma.
Lui si alza, osserva la dimostrazione scritta in gesso: mano sotto il mento, espressione assorta, gambe incrociate.
Dopo un minuto, si gira verso la classe.
"Qualcuno di voi ha capito qualcosa, di questa dimostrazione?"
Negano, rassegnati, le teste chine.
"Nemmeno io".
Alzano lo sguardo, increduli.
Un professore? Un professore di matematica che non capisce una dimostrazione? Non è possibile, anzi -rimaniamo in tema- è un risultato non accettabile, ma che storie sono!
Lui prende il cancellino e cancella ogni traccia di quei geroglifici.
Ora è tutto tranquillo, l'incubo è scomparso, i ragazzi, vedono di nuovo la pace su quella lastra nera.
Per chi vuole -dice lui- io ora la rispiego. Se non vi va di ascoltare, fate qualsiasi altra cosa, ma in silenzio.
Dal momento in cui posa il gesso sull'ardesia, la classe si incanta: sono tutti presi in una bolla di incantesimo di numeri, un tuffo in un oceano di somme, formule, equazioni ed espressioni.
Prima sembrava una fossa, quell'oceano!
Piena di scogli, mare dove naufragare senza aiuti, abissi senza luce, subisso di insufficienze.
Ed ora, mentre lui, tranquillamente, parla della circonferenza e delle rette che la intersecano, l'oceano appare meraviglioso, senza limiti, limpido e sicuro, galleggiare è così facile, e appena senti che stai per andare sotto, pahf!, un salvagente appare a sollevarti.
Lui va avanti, il gesso viaggia, disegna rette, marca punti, gratta via quella ruggine che si era attaccata al cervello dei ragazzi, gratta via il dubbio, gratta via la sfiducia, la paura di affondare nelle acque numeriche.
Conclude, la lavagna ordinatamente scarabocchiata di numeri, un disegno, un paio di formule. Dieci minuti ed è fatta.
Ecco, a me l'hanno insegnata così -dice piano- avete capito qualcosa?
Si siede, in attesa di risposte, scruta la classe.
Mentre attende reazioni, seduto sulla cattedra, elegantemente, studia la classe.
Aspettando sentenze, seduto sul bordo della cattedra -gambe accavallate e braccia incrociate- elegantemente vestito in giacca e cravatta blu -camicia azzurra-, contempla la classe, cercando negli occhi di ognuno qualche perplessità, qualche segno di vita.
E loro, quasi a bocca aperta, lo fissano.
Lo guardano stupefatti, lo osservano, cercano di vedere se ha delle ali, sotto la giacca, una coda, delle corna, vogliono capire se è umano -forse ha dei fili, è un robot?-.
Capelli sporcati dal gesso e la giacca con la manica imbiancata, frutto del troppo entusiasmo nella spiegazione, gli occhi che brillavano quando era arrivato alla fine -missione compiuta-, un accenno di sorriso soddisfatto nel vedere lo sguardo convinto anche di Rossella, la frana della matematica del liceo -rimandata ogni anno con il 4-, no, davvero: non poteva essere umano.
E poi un coro di sì, un'ondata di cenni con la testa, sorrisi, gioia di aver finalmente capito -ma allora non sono così stupido, la matematica la so fare!-.
E Il Professore -perchè ormai lo chiameranno sempre così, i ragazzi della 5H, la classe più impedita in matematica di tutto il liceo scienti-figo di Lanzé, comune vicino a Lanzano, dove la media delle materie scientifiche è 8 in ogni classe-, felice di questo successo, sposta lo sguardo tra gli alunni, poi guarda in un angolo, ultima fila a sinistra, di fianco alla finestra.
Una ragazza, stravolta, ne è rimasta incantata.
Aveva capito, sì, le si era accesa la famosa lampadina, si era aperta la porta, aveva trovato il salvagente a cui aggrapparsi.
Quella ragazza sarebbe uscita dal liceo scientifico a pieni voti, con una seconda prova impeccabile, e si sarebbe poi iscritta alla facoltà di matematica.
Quella ragazza ero io.
[va detto, anche se con poca convinzione: questa è una storia inventata, ogni riferimento a persone realmente esistenti è puramente casuale]
sabato 9 ottobre 2010
Coscienza

martedì 28 settembre 2010
domenica 12 settembre 2010

Dalla finestra della camera, la luce di un lampione. Il silenzio della notte.
Non la disturba un ronzio di zanzara, non il russare dalle stanze vicine, non il rotolante fruscio delle foglie in giardino.
Gli occhi, gli occhi si spalancano da soli. La mente non si vuole spegnere; nel momento in cui si inizia ad assopire, ecco che il pensiero ritorna, esplode nel cervello in mille frammenti che si conficcano nella testa, il dolore che si riapre, gli occhi scattano, aperti, annegati di lacrime asciutte.
Mai fissato il soffitto così a lungo, pensa. Mai l'ho odiato così a fondo. Trave, legno, trave, legno, trave, legno, nodo sul legno, trave, legno, trave.
Buio.
Ti odio, ti odio, sparisci dalla mia testa.
Come io non ci sono nella tua, ora,
come non ci sono mai stata,
come non ci sarò:
così sparisci senza lasciare traccia, vattene. Vattene
Preme un tasto della sveglia, l'ora si proietta sul muro in laser rosso tecnologico: mezzanotte è passata da molto. Una macchina passa in strada, con calma.
Non la tiene sveglia una canzone che le gira in testa, non è il caldo o il freddo, non è il letto scomodo.
Scivolano le pupille sulla stanza, sul soffitto.Si gira verso il muro, sposta il cuscino, lo rimette a posto bruscamente, si gira ancora, e ancora. Soffitto.
Chiude gli occhi.
"Conta le pecore, pensa a tutto quello che hai fatto durante la giornata, ai particolari, cerca di ripassare quello che hai studiato, rilassati per addormentarti."
Ma la mente divaga, si sposta ancora -cosa starà facendo? Cos'avrà fatto oggi?- e ritorna ad ogni suo ricordo, gli occhi si riaprono, due oblò nella notte, sbarrati. Bocca in giù, occhi in su, il soffitto la guarda. I ricordi la circondano.
Un ti odio altalenante, sempre meno convinto, fino a contorcersi in una domanda.
Ti odio?
Retorica, non è vero?
Una finestra si illumina, lontana. Un gatto in strada rovescia un bidone di bottiglie.
Non la distrugge un rimorso, un rimpianto, uno sbaglio passato.
Gli occhi seguono il filo di un pensiero, uno solo!, che tormenta e non lascia, che scivola nella tua ombra seguendoti costante. Ti risveglia al mattino e ti disturba la notte, notte sola e triste.
Guarda ancora il maledetto soffitto.
"Cadi, dai, cadi" lo sfida "La facciamo finita, così. " solo una tempesta di esagerazione, tanta scena per niente. Niente? Niente non è niente.
Ma ancora quel tormento ritorna, e la contorce dentro, stomaco, cuore, mente in un nodo armato.
Manca, manca. C'è qualcosa che manca. Qualcuno.
Il soffitto è lì.
Occhi aperti.
Il momento prima di esplodere, un secondo prima di iniziare a piangere come una bambina, un attimo prima di sfinirsi, allunga la mano e afferra da uno scaffale una grossa rana di peluche, morbida.
La abbraccia, il mento su uno sferico occhio di vetro. La abbraccia e la stringe forte.
La rana la consola con il suo sorriso cucito e la sua pancia di imbottitura. I suoi occhi duri e luccicanti spalancati al posto suo.
Piano piano il pensiero si addolcisce.
In fondo sa che dev'essere così solo perché sta crescendo.
Piano piano si addormenta, il peluche stretto a sè.
domenica 29 agosto 2010
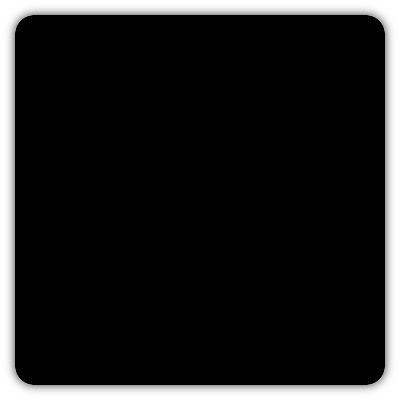
"Come topi. Come piccoli, repellenti topi che corrodono la carne, famelici di spazi dove moltiplicarsi, piccoli e disgustosi, malvagi topi. Sono ovunque, ovunque: non un buco dove non si acquattino nelle loro piattezze da scarafaggio insinuante, nascosti all'occhio dell'ignaro,
tu sei l'ignaro, sarai costretto a lasciare per loro, costretto
atti nella loro falsità, a guastare tutto ciò in cui sono, in piccoli buchi in cui si rifugiano, maledetti. Come insetti, sì, come insetti. Come insetti piccoli e neri, arrivano, giungono da dio sa dove, riempiono tutto della loro sgradita e sgradevole presenza, si spostano, sì, si spostano non visti, scivolano infidi in ogni angolo, nelle loro forme ottusamente piatte ma arrotondate, neri, schifosi e viscidi, come rotelle di verme, sanguisughe, piccole sanguisughe, disgustose sanguisughe nere e appiattite.
Vanno cacciati, vanno cacciati
E tutto nasce dalla crescita, dalla loro crescita, quando da piccoli e bianchi, ancora nell'essenziale forma sottile non disturbano, stando immobili nei loro nidi. Ma poi il tempo passa, e i piccoli diventano grandi, anneriscono nel colore dello scarafaggio, iniziano lo sviluppo in forme dall'irritante aspetto e consistenza. Un pugno nell'occhio da vedere, quando rovinano la purezza di ciò che è tuo, tuo e di nessun altro, tuo, tuo
Vanno cacciati, vanno cacciati, vanno cacciati, vanno cacciati
Cacciati!, con un coltello, estirpati, pungolati a forza a scendere e fuggire, precipitare dai loro rifugi sicuri verso una piattezza acquosa, ripararsi sotto i resti per poi essere gettati, fatti sparire, i corpi da invasori annegati nelle fogne o seppelliti tra la spazzatura, più trovati, mai più trovati, morti eternamente morti al nostro sguardo, morti
Vanno fatti sparire! Sparire per sempre, dalla faccia della terra, devono...”
Pomi?
Sì Popi?
E' possibile che ogni volta che mangi una fetta di anguria tu debba fare tutto questo casino?
Ma i semi...
Nonono, che ma, che semi. Sono le tre del mattino. Taci.
mercoledì 11 agosto 2010
Quasi una Cenerentola

domenica 4 luglio 2010
Vacanze al mare

Il pater familias prese la parola, a tavola. Come nel giorno annuale dell'annunciazione dell'orto.
“eora”
E già qui i volti dei figli, che presagivano già sventura, iniziarono a rivolgersi sempre più nei rispettivi piatti, le fronti imperlate di sudori freddi
“xe ora”
eh no, ma non è possibile, l'orto l'abbiamo già sistemato- si leggeva negli occhi
“che crompemo i biglieti par 'ndar al mare”
...sguardi allibiti si levano dai piatti di pasta: mare?
Ed era proprio mare. Con tanto di asciugamani e costumi, famiglia di amici con cui andare e macchina da prendere a noleggio.
I figli svennero.
Ovviamente, per una famiglia organizzata ai minimi storici quale HP è, l'andare in vacanza tutti e cinque assieme prevede una lunga odissea tra armadi e valigie per la preparazione intelligente dei bagagli e il tentativo -per quando flebile- di dimenticare a casa la minor percentuale di accessori indispensabili per una breve vacanza marittima.
Questo movimento preparatorio fu coordinato dalla Magistrale Organizzatrice -detta semplicemente mamma-, che in uno scandagliamento profondo di guardaroba, accompagnato da costante predicazione di preparare i propri fagotti, cercò di arginare i danni, cominciando il tutto all'inizio di Maggio.
Ovviamente i suoi consigli di anticipare il compito non furono seguiti, e quindi la sera prima della partenza le uniche borse ad essere pronte erano quelle preparate da lei, mentre i restanti quattro membri della famiglia si affaccendavano riempendo zaini e valigie con la tecnica dell'aspiratore a turbina (vale a dire arraffare tutto ciò che capita e scaraventarlo nel proprio bagaglio, in un vortice casuale, senza curarsi particolarmente di ciò che si è preso e senza fare particolare differenza se ad essere stato riposto è una pinza per dentisti o un costume da bagno).
Poi, la partenza. Ah!
Per seguire la classica vena alternativa che contraddistingue ogni iniziativa dell'HP, definendone il carattere bizzarro ed oltremodo disorganizzato, il pater familias optò per una partenza aerea alle setteequaranta. Il che significa una partenza automobilistica alle seiinpunto. Cioè una sveglia alle cinqueprecisesenonprima.
Considerando che la maggioranza schiacciante della famiglia era stata sveglia fino alle due, occupata nella preparazione dei propri bagagli, ciò risultò alquanto stancante.
In modo particolare fu sfibrante lo stipare nel bagagliaio della fedele auto i due borsoni, un trolley a forma di tigre, un cavallo a dondolo, una chitarra, due borse da spiaggia piene, una tracolla e uno zainetto in una disposizione mosaica e quantomai complessa ed instabile. Tanto instabile da far sì che, ogniqualvolta che il portellone veniva aperto per aggiungere un bagaglio dimenticato, -il che accadeva ad una frequenza media di un bagaglio ogni tre minuti e ventisette secondi- tutto il suo contenuto crollava a terra in un fracasso generale, mentre il pater familias ricordava animosamente il nome del signore e ricominciava poi rassegnato l'incastro, costretto a trovare una nuova strategia per far posto al nuovo pezzo del puzzle.
Si partì, dunque, alle seiequattrominuti, con rimprovero del PF per il ritardo, e conseguente accompagnamento di basso continuo per i primi quattro chilometri al ritmo di “no xe posibie, in sta casa, sempre in ritardo, no se parte mai giusti” (ad libitum sfumando).
La disposizione mosaicale del bagagliaio, poi, era rispecchiata nei sedili posteriori dell'auto, dovuto al fatto che i tre pargoli dell'HP non viaggiavano tutti insieme da lunghi tempi. Fu dunque uno shock per genitori e figli scoprire che il trio di bambolotti che un tempo si litigava lo spazio per allungare le gambe o posare la testa sul sedile si era ormai tramutato in un terzetto di mammut che non litigava più per il solo scopo di salvare ossigeno, carente in quella zona di macchina.
Ma in un modo o nell'altro, si partì.
I primi quattro chilometri, come si disse sopra, furono accompagnati dal borbottio paterno. A questo si aggiunse un fenomeno che dubito mancare in qualsiasi famiglia in partenza: il ritorno. Già, perché quale padre al volante può resistere all'estremo impulso di obbedienza che sferra la pietrosa e lacrimosa richiesta “papà, ho dimenticato il cellulare, torniamo indietro!”?
Questo si ripete dalle due alle diciassette volte -tale record si registrò nel 1932, quando una famiglia composta da otto membri, di cui sette di sesso femminile, si vide costretta a percorrere in un avanti e indietro tra la casa e la stazione dei treni una distanza pari a tre volte quella che sarebbe complessivamente dovuta essere per arrivare alla destinazione balneare-, ad intervalli regolari ma sempre più lunghi. Difatti, se la prima retromarcia viene innestata prima dell'uscita dal vialetto di casa, l'ultima inversione a u sarà fatta a tre chilometri e mezzo dal cancello. Dell'aeroporto, sia chiaro.
A questi fattori di rallentamento si aggiunge l'occasionale brusco arresto a causa di un attraversamento pedonale di una famiglia di quaglie composta da quarantasette elementi, ma la cosa è alquanto rara.
Partiti, dunque. E miracolosamente, il numero dei ritorni tempestivi si era limitato a due, in un tempo relativamente breve.
Come un paio di jeans aderenti si adatta alle forme di chi li porta, allargandosi ed ammorbidendosi, permettendo alle cosce di respirare e all'indossatore di pensare di essere dimagrito miracolosamente, così la macchina si adattò alle forme dei tre giovani mammut, lasciandoli mano a mano liberi di compiere perlomeno i movimenti necessari.
Questo non fu proprio positivo, perlomeno per chi abitava i sedili anteriori.
Difatti, per supplire alla grave carenza di sonno, il trio bananas aveva consacrato la sveglia al sacro rito del caffè, ingurgitandone una media di tre tazzine a testa. Considerando che due dei tre non avevano mai assaggiato cotanta bevanda, gli effetti furono deleteri.
La macchina implose di note.
Ognuno dei tre giovani, ovviamente dotati di Ipod funzionante e perfettamente carico attaccato alle orecchie, eccitato dalla partenza finalmente riuscita e dalla caffeina, iniziò a canticchiare, aumentando il volume esponenzialmente, e dimenarsi nel minimo spazio concesso sulle note e i ritmi più disparati: essendo poi tre i fratelli e tre le canzoni in ascolto, il tutto creava una cacofonia insostenibile, in un crescendo di tensione dell'autista e di passione dei cantanti, sempre più eccitati e divertiti e appassionati nella loro prestazione canterina... Un secondo prima dell'esplosione del pater familias, a ciò fu posto rimedio: un Ipod -uno solo!- fu collegato alla radio, e si ascoltò una canzone per volta.
Purtroppo i ritmi accelerati dalla caffeina facevano sì che il tempo dopo il quale i tre erano già stanchi e cambiavano canzone -litigandosi l'Ipod per poter prendere il comando dell'ascolto- ondeggiava tra i quindici secondi ed il minuto e mezzo. Un ritmo insostenibile per i genitori, i quali, vedendo come unica alternativa il sentirsi cantare contemporaneamente canzoni di Lady Gaga, ACDC e Beatles, si rassegnarono, chiedendo però perlomeno una momentanea tregua per le loro orecchie.
Fu dunque deciso che si sarebbe ascoltato “My Sharona”, in religioso silenzio.
Al terzo “Myyysharona!”, però, la tensione e il desiderio raggiunsero picchi indomabili, e il trio esplose in un coretto che non si arrestò fino all'aeroporto, se non per eventuali pause per esclamazioni quali “tra quanto arriviamo?” “ho dimenticato l'alimentatore della macchina fotografica! TORNIAMO INDIETRO!” e “oh papà, ti stai facendo superare da una Fiat Idea! ...E anche da una Wolksvagen del 30 avanti Cristo! Che scrauso!”, sentenza che determinò una brusca accelerazione ex abrupto.
Fu solo dopo un'ora e mezza di viaggio, a ritmi vari ma pur sempre insostenibili, con la caffeina il cui effetto era sempre più vacuo, che da un mantello denso di nuvole si aprì uno squarcio dal quale sgorgò un raggio di sole ad illuminare l'aeroporto!
L'arrivo e il parcheggio, secchi e in ritardo quel tanto che basta per far innervosire ogni singolo elemento familiare -compreso il cavallo a dondolo-, furono una cosa sola, così come lo sbarco e lo scaricamento bagagli: tutta d'un balzo la HF scese dalla vettura, abbrancò le valigie senza badare all'ordine e trottò verso l'entrata, i trolley che inciampavano nelle scale mobili e i piedi che incespicavano per il sonno.
L'arrivo al check-in, un minuto prima della chiusura degli imbarchi.
“Happy Family, sì. Sì, tre figli... Ecco, s... Il passaporto? No, non ho il passaporto: non è un volo interno? ….come sarebbe a dire che serve il passaporto? Le foto dei figli? Sì, sono minorenni, ma... Mi dica: potremmo imbarcarli con le valigie?”
Mentre i quattro disorganizzati impallidivano per la carenza dei documenti dei due fratelli minori, la Magistrale Organizzatrice ghignò, sprezzante.
Poi, con un gesto scenografico, come un veterano giocatore di carte che sfodera il suo poker d'assi, estrasse il suo passaporto. Con gesto di ventaglio -leggero movimento di polso e l'aria di sufficienza ancora sul volto-, sbucarono da dietro il libretto i documenti del pater familias -flap! A destra- e della figlia -flap! A destra-.
“ecco i tre passaporti. Si, gli altri due figli sono nel mio. Ecco le valigie... Sì, i biglietti li dia a me. Grazie”
giovedì 1 luglio 2010
Come un comò

mercoledì 14 aprile 2010
Il Rapido

Il rapido va: slitta, scivola, binari, terra, sassi, case, tutto passa e svanisce, non perde un attimo. Attorno a lui c'è una giornata che si sta svegliando, ma il rapido non si ferma, non si arresta, corre, scappa, fugge. Velocità costante, sfreccia senza posa, corre senza pausa, scappa dalla stazione precedente, poche curve, linee rette, fugge appiattito al suolo per non sentire il vento che gli soffia contro, corre, scappa, fugge. Macchine come topi impazziti, nelle corsie delle strade vicine ai binari ansimano al suo fianco per stargli al passo, ma il rapido corre, scappa, fugge.
Sono le sette di mattina, il convoglio è abbastanza pieno, riempitosi in fretta alla stazione nella pressione delle valigie attraverso le porte, il caos del ritardo, la corsa contro il tempo per saltare dentro e non rimanere a piedi; nella carrozza di seconda classe c'è qualche posto vuoto, prontamente occupato da bagagli a mano degli altri passeggeri.
Qualche altro posto resta libero, nella carrozza di seconda classe. Il treno è partito precisamente alle 6.43, con dieci minuti esatti di ritardo.
Ora corre. Scappa. Fugge.
Lei gioca con l'anello al dito, lentamente. Guarda fuori dal finestrino -vetro graffiato di scritte oscene-, alla sua sinistra, seguendo placida dei residui dei sogni della notte precedente, ormai irrimediabilmente spenti e sgretolati, i loro frammenti volano fuori dal finestrino, risucchiati dall'aria vorticosa. Il cerchio d'argento, liscio, si avvita sulle falangi, scende e risale, ma non si sfila mai.
Lo sguardo di lei si dirige lontano, dove la lentezza dell'interno del rapido è pari a quella dalle montagne appena visibili nella foschia del mattino: macigni immensi che scorrono con la tranquillità della vecchiaia e la saggezza della vita vissuta. Per quanto il rapido scappi, il paesaggio è lo stesso per chilometri e chilometri, lo segue da lontano in uno sberleffo minaccioso. Nel mezzo, tra l'interno del treno e il paesaggio discosto, le cose strisciano via in una frazione di secondo: le case, gli alberi, persone, animali, campi, così piccoli e giovani di fianco alle montagne, loro sfrecciano seguendo il treno, scappano con lui, svaniscono in fretta come vanità umane. Il paesaggio lontano e saldo resiste, accompagnando il viaggiatore per chilometri. La terra rimane, il lontano non si raggiunge mai: si segue per un tempo infinito, ma lontano è, e rimane lontano. Poi a un certo punto -è un attimo- sei là, ed è finalmente vicino, e per poi sparire anche lui, dal finestrino del rapido che corre senza posa.
Pigramente una mano di passeggero passa su una pagina, seguendo le parole svogliatamente. Il libro posato sulle ginocchia pare eterno e destinato a non finire mai.
Un'altra mano, qualche sedile più in là, distratta carezza i capelli e una guancia a un bambino assonnato. Le dita scivolano lente, la pelle è morbida. Due fratelli, vanno a trovare il padre. La mamma non viene.
Una terza mano scivola sul vetro del finestrino, lenta, sciogliendo il vapore che si è formato per il freddo della mattina di Gennaio. Togliendo quella cortina di bianco, si scorge la rapidità delle cose che scivolano, un buco sulla velocità, uno sguardo al mondo là fuori, teso e scattante, mentre dentro tutto è allentato nella lentezza all'interno del rapido.
Il torpore rilassato di un addormentato abbandonato sul sedile, bocca aperta, respiro regolare. Emana lentezza dal sonno del viaggiatore esausto, uno stagno nero in cui sprofonda senza sogni né coscienza.
Fuori il sole -lontano, più lontano delle montagne- inizia a sorgere, ed è sfinente quanto sia millimetrico il suo salire, senza fretta, mentre il treno non si ferma ad ammirarlo e lo nasconde dietro le case che sorpassa, allineate e lontane dai binari, allineate e davanti al sole che sorge, lento. Colore sanguigno.
Dei passeggeri lo guardano, e per chi ha fretta di arrivare è esasperante il tempo che non passa, è logorante per chi legge i secondi dal quadrante dell'orologio, aspettare le ore per finire questo viaggio, ore che non passano, che si trascinano nella lentezza all'interno del rapido.
Una penna annota qualcosa su un'agenda. Inchiostro nero, foglio bianco a righe, indica una data di qualche anno passato. Lo scrittore si guarda attorno, svogliatamente, annota e si riperde a contemplare il paesaggio -il sole è ormai sorto- e i suoi compagni di carrozza.
Il controllore passa, trascinando un po' i piedi per l'intontimento stanco del mattino. La borsa gli sbatte su un fianco, mentre avanza chiedendo i biglietti, lento e stanco nella lentezza all'interno del rapido.
La lentezza del distratto che rinviene, del filo di pensiero che si taglia e ondeggia nel vuoto come un filo di ragnatela, per tornare alla carrozza di seconda classe e cercare il biglietto nella borsa.
La lentezza della pazienza di chi ha trovato un compagno di viaggio chiacchierone, pronto a raccontare in ogni particolare la vita, sua, della famiglia e del paese da cui proviene.
La lentezza dello sfiorire di tutti, secondo dopo secondo, mentre a bordo del rapido fuggono dal passato.
La lentezza di un attimo, in cui tutto si ferma.
La rapidità dello schianto.
mercoledì 31 marzo 2010
L'orto

La frase che dà inizio alla parata è “xe ora che scumisiemo a far qualcossa par quel orto”, tradotto: “è ora di cominciare a far qualcosa per quell'orto”. Questa locuzione rappresenta il preludio all'odissea, l'annuncio dell'epopea, il segnale della sventura che sta per abbattersi sulla nostra casa.
Per rendere meglio l'idea, però, va prima creata un po' di atmosfera.
Come ormai si sa, la mia famiglia e i relativi animali abita a Lanzano, una sperduta comunità di origini agricole, che risulta essere un perfetto esempio di “morte civile” veneta. Va precisato, però, che noi non abitiamo a Lanzano centro.
Noi siamo fuori.
In mezzo ai campi.
Voglio dire, se abitassimo davanti alla chiesa non potremmo tenere oche da guardia; la rumorosa happy family sarebbe presto cacciata; l'inquinamento della cittadella aumenterebbe esponenzialmente nel giro di una settimana, a causa dei continui spostamenti in macchina che mia mamma è costretta a fare.
Dunque abitiamo in campagna. Grande giardino, le suddette oche da guardia, nidi di vespe ovunque e, nei primi tempi, anche un discreto giro di pantegane -vale a dire grossi ratti-, che fu prontamente sterminato dall'armata felina che pattuglia la proprietà.
Oltre a tutto ciò, un grande orto.
È questo il più grande orgoglio di mio papà: il suo amato orto, di cui quando parla gli si illuminano gli occhi, nel quale passa le giornate più afose a seminare tuberi, con il quale tormenta la vita dei tre figli ammonendoli che i peperoni si stanno seccando e così lanciando l'implicito ordine: “vai a dargli da bere”.
Quest'orto, va precisato, è bello. È stato curato, studiato, seminato, arato per anni. Un esercito di giardinieri è intervenuto a restaurarlo più volte, creando deliziosi corridoi con pergole tra le aiuole e le rose e cambiando o rinforzando i pali su i quali si arrampicano le piante di fagioli.
Due spiazzi di terra sono occupati da coltivazioni di fiori selvatici che la mamma -curatrice estetica del complesso- semina in estate. L'uva rende quel posto dolce in autunno, e le fragole ai lati delle aiuole lo colorano in estate, sfumando dai toni del verde al rosso acceso. In inverno si spegne, ma quando è coperto dalla neve pare un giardino segreto, magicamente.
È la primavera, il problema.
La prima giornata di sole, di solito, con una temperatura che supera quei dodici-tredici gradi che a causa del freddo impediscono di uscire in giardino alla parte in letargo di un contadino della domenica. La mattina di tale giorno, mentre i figli sono a scuola, il pater familias parte per un'esplorazione. Armato di tazzina di caffè, dopo colazione gironzola guardando lo stato dell'orto e scuotendo la testa, per poi fare un giro completo del giardino iniziando a macchinare come riprendere il controllo della situazione ortobotanica casalinga. La moglie, preoccupata ed armata anch'essa della sua tazzina di caffè -verde, la tazzina, senza manico a causa di una sfortunata caduta dalla lavastoviglie-, lo guarda dalla porta finestra, preannunciando guai.
È però solo all'ora di pranzo che viene sganciata la bomba: “xe ora che scumissiemo a far qualcossa par quell'orto”.
Sguardi di terrore circolano attorno al tavolo.
Il “far qualcossa par l'orto” non è una frase traducibile con una sola propostizione in italiano: essa è però riportabile attraverso tre diverse locuzioni.
Il primo significato, il più esplicito, con il quale si può spiegare cotanta minaccia è “bisogna cominciare a lavorare in giardino”. Armarsi quindi di forconi, pale, stivali di gomma e vecchi maglioni, per passare qualche ora a smuovere la terra, estirpare le vecchie piante, togliere le erbacce e dissodare il terreno, dacché in questa campagna veneta pare che le pietre mantengano un ritmo di riproduzione vertiginoso e costante. Leggenda narra che siano vere e proprie patate, dimenticate dall'agricoltore e -indispettite da tale dimenticanza- tramutatesi in sassi per rompere le lame dell'aratro, obbligando così lo sfortunato contadino ad arare i campi a mano. La questione si risolve dunque lavorando in giardino, le mani nel fango e la terra sotto le unghie, il tutto in religioso silenzio, salvo eccezionali insulti ai sassi che impediscono l'attività.
Comunque sia, quest'anno l'attività di estirpazione ha raggiunto livelli da record: mai, infatti, si era visto papà estirpare alberi di melanzane.
Alberi, dico sul serio.
Le innocenti piantine, non essendo state estirpate alla fine della stagione, avevano continuato la miracolosa crescita, probabilmente anche assorbendo tutto il nutrimento presente sul terreno che sarebbe stato destinato a far crescere giovani virgulti per il prossimo decennio.
Il secondo significato è la semina.
Può sembrare un'innocente attività orticola, ma non è così. Alla semina è precedente un'attenta pianificazione: dove porre le piante? I criteri per la sistemazione (anche se “sistemazione” poi non è assolutamente il termine adatto: consociazione o rotazione delle piantine sarebbe più confacente) sono vari: influiscono aspetto estetico (il giallo dei peperoni si intona al viola delle melanzane?), strategico (quanto pesa una cesta di pomodori rispetto a del radicchio? Il radicchio viene quindi piantato nell'aiuola meno lontana dalla porta di casa), temporale, culturale (il contadino veneto è dotto di proverbi agricoli quali “a San Valentin se verse l'ortzin”, “se te voi un bon bisaro, semena in febraro”, “Marzo ventisá, april temperá, contadin fortuná”, i quali vengono ripetuti a ruota nei periodi di semina). Influisce poi ovviamente il lato biologico e scientifico, e infine quello bellico: la guerra contro i parassiti non è mai finita.
Alla semina segue la fertilizzazione, e qui preferirei stendere un velo pietoso.
Ultima ma non meno importante delle tre frasi incluse nel verbo contadino è “rassettato l'orto come si deve, adesso bisogna mantenerlo in questo stato”.
Questo non è facile.
Non solo le piante varie crescono e -secondo me- si spostano durante la notte autonomamente. Ma i sassi prolificano, le erbacce invadono, le aiuole cedono. Bisogna quindi quotidianamente passare a rassettare, strappare, tagliare, e ovviamente raccogliere prima che i frutti del duro lavoro vengano mangiati, crescano smisuratamente fino a raggiungere i cinque chili di peso e diventare immangiabili, o cadano miseramente riempendosi di buchi di insetti e marciume.
Va inoltre fatta la guardia perché le oche non decidano che lo spuntino pomeridiano consiste in radicchio fresco.
Questo era successo l'anno scorso, quando ancora non conoscevamo bene i nostri pennuti. Il radicchio era stato amorosamente cresciuto, papà l'aveva coltivato fin dai semi. Piccoli e teneri virgulti mettevano radici e sviluppavano gli embrioni di foglia.
Erano stati piantati, rovinando vertebre e spine dorsali, coperti da teli e protetti come cuccioli indifesi. Terrorizzati dallo stomaco omicida dei nostri pennuti da guardia, tenevamo sotto costante controllo l'orto, preoccupati che da un momento all'altro il lungo lavoro di papà potesse sparire nel becco delle due oche.
Vedendo che la coppia passeggiava nell'orto senza mostrare interesse per i piccoli radicchietti, ci rilassammo. Ormai i radicchietti erano diventati radicchioni, prosperosi cespi di foglie rigogliose, pensavamo troppo grandi per indurre i palmati in tentazione. Scemi noi.
Un pomeriggio, papà passeggiava. Volse lo sguardo all'aiuola dei protetti, e vi trovò il nulla. Tabula rasa. Piazza pulita. Solo due grossi pennuti bianchi accovacciati, che senza riuscire ad alzarsi per lo stomaco pieno, lo guardavano soddisfatti: avevano aspettato che il raccolto diventasse abbondante, per poi dedicarsi a una soddisfacente abbuffata notturna.
E li chiamiamo stupidi...
martedì 5 gennaio 2010
Esercizi di Stil II (dialetto veneto)

Ben cari, Irma, te savessi cossa che me ga tocà vedar che altro dì sul bus!
Iera mesodì, e tornando dal marcà impinia de sporte fin sora i cavei, so' montada su na coriera de a linea 44. Te sè el casin che ghe xe a quell'ora, tuto un spintonarse, e dirse su, e scuseme che go da smontar, e spostate che go da montar, e asame el posto, e fora dae bae che go da sentarme -eh, Irma, bisogna adatarse al linguagio, o no i te 'scolta mia, sti tosi de 'ncò! Tuto un bevar, drogarse, dir paroease.... No ghe xe pì a gioventù de na volta!-, insoma, un casoto che no sto a contarte.
E tra na cosa e che altro, tra tuto sto maceo ghe iera un bocia che'l parea un tachin, adobà co na bareta che no te digo, tuta incordonada, ma bruta!, che co sta moda de 'ncò mi veramente no capiso pì niente, e insoma ghe iera sto bocia che'l iera drio dir su a un toso pì grando de iù.
Ma setu cossa che ghe iera che ghe dava fastidio al bocia-tachin? Che l'altro ghe pestava i pie tute e volte che qualchedun l'entrava ne a coriera!
Te vedesi che mestieri! E poi, quando che ga visto che l'altro toso iera pì grando de iù, el voeatie el xe scampà suito e el xe ga butà su un sedie vodo invese che asarmeo.
Ma neanca dirlo, o go impinio de pache in testa co a sporta de e verdure! Ghe go sfondà a testa co un ananas!
E ben, Irma, ghe voe un poco de queo che se dise, un poco de creansa! El xe scampà via de corsa! Sacramento, Irma, ga da essarghe un poco de rispeto par noialtre vece! El me poro defunto Bepi -pace all'anima sua- nol gavaria esità a asar el posto a una pora vecia. Lù sì chel iera un brav'omo.
Ma insoma, dopo sto spetacoeto son 'ndada casa, e dopo un par de ore, quando che son 'ndada fora da novo par andar aea rinunion del circoeo dea canasta, go catà da novo el ceo, sempre co quel capeo che me fasea pecà soeo che vedarlo, e stavolta el iera co un tosato de a so età, drio sbarufarse e questionar su un boton del paltò del toso-tachin.
Ben cari, Irma, no ghe xe pì e mese stajon! Col paltò de lana in aprie!
Ma che rasa de storie...
E di nuovo, tutti a tavola

Generalmente l'onda arriva pochi giorni dopo il luculliano banchetto natalizio, senza minimamente dare il tempo necessario per lo smaltimento degli avanzi del suddetto pasto e della sabongia di calorie assunte nello stesso giorno a suon di lessi e pasticci.
Dopo tre lustri passati con quattro ospiti a vacanza, per giunta per non più di cinque giorni, quest'anno gli astri vollero che non solo gli amici storici venissero, puntuali, la sera del primo Gennaio, ma che dal trenta Dicembre pomeriggio fosse già qui presente un'altra famiglia oltre alla mia. Più un' amica.
Totale delle persone prima di Gennaio: dieci.
La casa, solitamente, ne contiene a mala pena cinque, che si spartiscono malamente gli spazi invadendo l'uno il casino dell'altro.
Ora siamo in tredici, perché l'amica della prima famiglia è partita, ma ieri sera si toccò il picco mai raggiunto di quattordici convittori in un colpo solo, tutti accampati in qualche modo in giro per l'alloggio. Accampati, vorrei sottolineare, perché i posti letto ufficiali sono sette.
In via del tutto eccezionale si sono duplicati, straordinario avvenimento il cui merito va riconosciuto a due letti pieghevoli, un lettino da bebè, un divano letto mai usato e due materassi reperiti in qualche modo onde far scartare alla padrona di casa l'idea di mandare qualche membro della famiglia albergatrice a dormire in macchina con coperta e cuscino. Probabilmente per la paura di essere noi gli sfortunati, tra me e relativi fratelli si scatenò una caccia al materasso spietata, nella quale fu anche carezzata l'idea di spennare le oche e le galline abitanti in giardino per poterne costruire uno nuovo.
Comunque sia, in qualche modo i giacigli furono arrangiati senza spargimenti di penne, ed ora, dopo aver sistemato ciascuno di noi in una camera dotata di letto e coperte, le giornate passano più o meno nel seguente modo.
Innanzitutto, è stata ormai ufficializzata la mattina breve, nel senso che l'ora della levata dalle brande oscilla tra le dieci e mezza e mezzogiorno e mezzo. Ovviamente la colazione non viene saltata, e dunque il tavolo resta occupato ed imbandito finché l'ultimo degli abitanti non ha saziato i suoi mattinieri appetiti.Attenzione però all'imbandimento del desco, particolare che ben definisce e rende la calorica idea che in questa casa accompagna da sempre le vacanze in compagnia.
Nell'attuale epoca, in cui mentre metà della popolazione mondiale muore di fame, l'altra metà sta a dieta, ci si potrebbe aspettare una colazioncina leggera: caffettino, biscottino, e magari una fettina di pane con una marmellatina senza zucchero.
Da noi, panettone.
Non solo: lo accompagna l'inseparabile variante del pandoro, il tutto ben scortato da sifoni di crema di mascarpone -l'onnipresente e caratteristica bomba calorica che distingue il periodo natalizio da quello pasquale-, cappuccini e un numero non ben approssimato di moke da cinque di caffè, qualche panino avanzato dalla cena, marmellate e cornflakes, quindi fiumi di latte fresco e pannoso, cartoni di latte di riso al cioccolato e alla mandorla, e in certi giorni anche alla vaniglia.
La tavola, una volta che tutti si son soddisfatti, viene sparecchiata e imbandita per il pranzo, che si svolge tra le tre e le quattro e mezza. Con questo, è possibile notare quanto essenziale sia la presenza costante di cibo e di personale culinario che assista gli affamati.
Non essendo questa casa dotata di maggiordomi e cuochi , il ruolo è adempito dalle mamme, che tra una mescolata di crema di mascarpone e una moka di caffè passano la giornata tra i fornelli, cucinando armate di Bimby, lavando interminabili pile di piatti e mucchi di stoviglie e poi rassettando. Splendido esempio della cosiddetta emancipazione femminile.
Mentre le signore spignattano, il resto della mandria si spartisce i ruoli di fondamentale importanza nel consumo dell'energia accumulata durante gli abbondanti pasti, quali: utilizzo ossessivo-compulsivo di videogioco Wii, costante strimpellamento senza convinzione da parte dei musicisti presenti, controllo orario di Facebook per i giovini e baldi non occupati in babysitteraggi o partite virtualmente calcistiche, discussione intellettualmente rilassata, ampi e ciondolanti giretti in giardino per respirare un po' d'aria buona e, aiutati dal freddo, bruciare qualche caloria.
A pranzo, si pone il problema dei letti traslato sul tavolo, anch'esso solitamente spartito alla meno peggio tra cinque persone e ora posto davanti a ben quattordici commensali affamati. Alla prima cena in quattordici fu chiaro che non solo non sarebbero stati sufficienti i posti, ma lo spazio per le vivande una volta disposti i piatti sarebbe stato inesistente.
La difficoltà fu immediatamente risolta con una basale divisione in turni dei pasti: i bambini al primo giro, gli adulti al secondo. Le mamme in cucina in ogni caso.Si noti però l'ingiusta conclusione: a differenza del primo turno, infatti, terminato in fretta e furia per sparecchiare e preparare il posto e il pasto ai grandi, il secondo turno si trascina con ampio strascico, protraendosi a volte fino alle quattro e mezza, addirittura cinque. Concludendosi tra l'altro caloricamente con fette di dolci avanzati dalla colazione e dalla festa dell'ultimo dell'anno, tra cui spiccano i famosi struffoli (trattasi di ammasso di pallette di pasta fritte, legate da miele e arricchite nell'ammasso da zuccherini e canditi. Presentano la dietetica caratteristica di non permettere a chi si azzarda a mangiare una singola pallina di poi fermarsi prima di essersi cementati i denti a suon di palle di pasta e miele. Una volta fatto ciò, infatti, rendono impossibile l'apertura mascellare, chiudendo così la bocca a stimoli famelici e raptus da pasto. Purtroppo la quantità di pallette da ingerire prima di cementare la cavità orale è sufficientemente grande da sfamare un'orda di barbari affamati, dunque la proprietà dietetica del dolce è poco sfruttabile) e i pandori e panettoni della colazione. Immancabile la presenza di almeno una terrina di irrinunciabile e tentatrice crema di mascarpone.
Verso le cinque, la cucina è lasciata alle mamme in chiacchera libera mentre riordinano.Qui vengono toccati argomenti a cui nessun'altro presente in casa ha accesso: sono discussioni misteriose, continue e apparentemente anche appassionanti, in quanto possono durare costantemente durante l'occupazione della cucina.
Capitolo con significativa importanza in tali discussioni è quello riguardante cosa preparare per la cena già incombente. Dopo aver controllato il frigorifero stipato di avanzi che ancora risalgono al pranzo di Natale e aver deciso che non c'è niente di già pronto per il pasto serale, le signore escono a bordo della prima macchina disincastrabile dal puzzle di automobili presente nel cortile, alla volta del supermercato, dal quale ritornano vittoriosamente trascinando borse della spesa straripanti dopo una quantità di tempo variabile, in generale definita dalla quantità di botteghe con vetrine in saldo incontrate nella via.
Il tempo di incastrare le spese nella dispensa e decidere cosa preparare occupa tutto lo spazio disponibile: è quindi già ora di accendere i fornelli.
Nel frattempo il bimbo treenne messo a dormire alle quattro si è risvegliato, e richiede giochi alla nuova tata, sollevata dal ruolo di figlia da perentoria affermazione al padre della suddetta: “non è tua figlia, lei è la mia tata”.
La casa viene rivoltata come un calzino alla ricerca di pedine mancanti a giochi da tavolo evidentemente estremamente attraenti per il piccolo, le scatole di animali sono rovesciate ed esplorate in profondità, i lego costruiscono grattacieli a dimensioni reali che vengono poi abbattuti a martellate, scagliate con attrezzi di forma non ben ben definita ma di origine certa, quale la grande cassa in cui vanno nascoste tutte quelle cose che non trovano ordinato posto altrove.
Conclusa l'odissea nella stanza dei giochi, viene invasa la camera da letto più accessibile e meno pi ena di letti da campeggio, tramutando il talamo in nave pirata immaginaria e, lanciati peluches d'ogni forma per tutta la stanza, tuffandosi in mirabolanti salvataggi in mare aperto, combattendo squali feroci e meduse assassine.
Salvati i pelosi giocattoli viene fatta un'ampia selezione di videocassette e dvd da guardare dopo cena. La media di video scelti è di quattro a sera.
Poi viene il momento -breve- del disegno, della musica e dell'avventura in giardino, dove a bordo di un catorcio che un tempo era una ruspa a pedali arancione fiammante, si vanno a trovare i palmati volatili accampati in fondo al campo, si rincorrono gatti dalla coda storta e si cercano uova inesistenti di galline dallo strano ciuffo.
Ed è subito sera, e tutti sono nuovamente riuniti al grande tavolo debordante pietanze.
Stabiliti e litigati i turni, si allungano le mani sui piatti e in un attimo i bambini hanno finito il pasto e sono tornati con energia rinnovata e pancia piena ai giochi lasciati sospesi, pronti a terminare l'ennesima partita di Wii e ad addormentarsi davanti ad un video in divano.I grandi si siedono, e mangiando si abbandonano a considerazioni, pensieri e propositi.
Primo tra tutti: da domani, dieta!, ribadito da abbondante mestolata di crema di mascarpone di mezzanotte schiantata sul piatto, assaggiando ancora però gli struffoli alla cui presenza oramai tutti sono rassegnati, e condendoli con una certa crema al cioccolato che proprio non si poteva non assaggiare.
È infine l'una quando tutti si lasciano, andando a rintanarsi nei propri rifugi notturni. Strillando, ridendo, sbadigliando, tutti si avviano.
E le mamme pensano già a cosa mettere a tavola domani, per colazione.
Maturità Immatura

Trovava immaturi i suoi coetanei: gli adolescenti. Era una cosa che le capitava da sempre, anni e anni di giovinezza a osservare gli amici e trovarli irrimediabilmente infantili, comparandoli continuamente con i suoi miti di perfezioni e esempi di comportamento: gli adulti. I genitori, gli amici, i nonni, vari membri della famiglia, scrittori, giornalisti, professori, personaggi che vedeva per strada, nei film, che leggeva nei libri, persone con cui parlava alla fermata del bus, genitori degli amici. Gli adulti, insomma. Modelli senza difetti che si era prefissata e che voleva raggiungere.
Cercava di imitarli in quella loro maturità, ma nonostante il tempo passasse, gli anni si sommassero e lentamente la maggiore età sopraggiungesse, ogniqualvolta si trovava a confrontarsi con un intimidatorio e puntualmente impeccabile essere adulto si sentiva la bambina della situazione: troppo impreparata alla vita e poco saggia. Non capiva di crescere e che, in fondo, maturava veramente anche lei.
Allo stesso tempo continuava a sbirciare ai comportamenti dei coetanei, trovandoli come sempre infantili. Poi si voltava dall’altra parte, sospirando dietro ai suoi sogni.
Un giorno, a venticinque anni, si accorse di essere cresciuta. Di essere un’adulta anche lei, voglio dire.
Era un’affollata mattina primaverile, in autobus, quando guardò agli uomini e alle donne che la circondavano. Era già qualche tempo che ogni volta che aveva qualche contatto con questi nuovi adulti aveva un senso di fastidio, un qualcosa di noto ma che non ricordava, qualcosa che la faceva sentire fuori posto e –vergognosamente- altezzosamente superiore. Le pareva di averla già provata, quella sensazione, ma non riusciva a capire quando e perché.
Osservò a lungo e cercò di ricordare, insomma, sbirciando di sottecchi, anche apertamente, e dopo un po’ capì.
Prese un respiro, alzò lo sguardo, e si accorse che come era stata abituata a fare con tutti i suoi coetanei in qualsiasi momento della sua vita, guardava agli adulti e li trovava estremamente infantili.