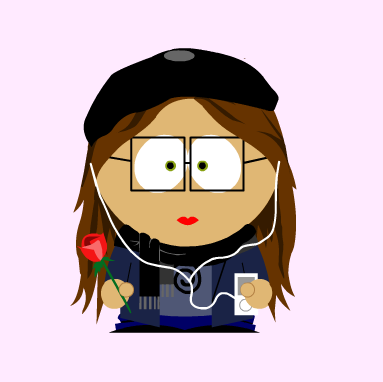Da alcuni anni pare che casa nostra sia territorio particolarmente appetibile per gli invasori.
E adesso non cominciate con le accuse leghisti di qua, leghisti di là, e il Veneto leghista eccetera eccetera: la mia è una constatazione oggettiva di una cittadina italiana che non sa più cosa fare con questi fastidiosi parassiti che circondano e riempiono il nostro territorio, le nostre case e le nostre città, impedendo le attività più semplici e infastidendo chiunque in maniera insopportabile ogni volta che te li trovi lì davanti, con quello sguardo ebete, che ti fissano.
Fa razzista, ma non ci posso fare niente: li odio, i colombi.
Odio colombi e formiche, a dirla tutta, ma perlomeno le formiche tacciono e non ti gorgogliano fuori dal balcone alle sei del mattino.
Non sopporto colombi e formiche, ok, ma le formiche non scagazzano in giro per il portico, corrodendo le colonne e rendendo lo spazio impraticabile e a rischio di bombardamento in testa a meno che tu non ti protegga con un elmetto –o ombrellino, per le signore-.
A buttarla così pare che i pennuti siano una catastrofe universale, piombata nel pianeta terra come punizione divina per i nostri eterni peccati.
Effettivamente, lo sono. La catastrofe universale, voglio dire; poi se fossero anche una punizione divina, la cosa potrebbe solo rallegrarmi: c’è la speranza che, scontata la pena, i piccioni spariscano.
Questi uccelli, comunque.
Ma non hanno proprio nulla da fare, durante il giorno?
Ma che senso ha, quando a pochi chilometri c’è Venezia con i suoi squadroni di turisti armati di briciolosi panini, con le sue vecchiette che vendono becchime, con tutto il suo ambaradam che crea un perfetto habitat piccionico, che senso ha, dicevo, andare a stabilirsi in massa in un’innocente casa in campagna?
Uno degli innumerevoli segreti di Fatima, dovesse essere mai svelato, vi avverto già che riguarda questo quesito.
Quesito al quale qui in famiglia, l’anno scorso, trovatici con il portico della casa diventato condominio piccionesco, abbiamo smesso di cercare risposta per passare all’azione diretta: trovare una soluzione pratica, veloce, definitiva.
Dovete sapere che in casa mia siamo dei ghiri pazzeschi. Pazzeschi ma un po’ anomali, purtroppo: siamo tutti ben dotati di sonno estremamente leggero verso i rumori più assurdi.
Che so, ci fate partire un martello pneumatico sotto casa, e noi pacifici continuiamo a ronfare.
Cade un cucchiaio in cucina, però, e ci svegliamo di botto tutti.
In ogni caso, per farla breve, una mattina ci siam svegliati e sonno ciao, sonno ciao, sonno ciao ciao ciao, una mattina ci siam svegliati e abbiam trovato là i piccion.
Una coppia che tubava allegramente, ovvio, due giovani pennuti felici di aver trovato una comoda sistemazione a quattro camere con vista sul giardino.
Sapete, queste sono le cose che proprio ti fanno salire un giramento di scatole che non ti molla più, specie se avete ben presente il verso dei piccioni.
Voglio dire, il piccione almeno avesse un allegro cinguettio che ti sveglia che è un piacere anche alle quattro del mattino.
Fosse sempre stato noto per le capacità risveglianti.
Avesse un bel tono di voce, fosse anche basso e monotono o squillante e acutissimo, quasi una specie di violino con la coda e le piume.
No. Il piccione ha quel mezzo tono borbottato e martellante, un sussurro a sfondo semi-erotico che ti risveglia dal sonno più pesante, quel gru-gru che già da sotto le coperte ti fa pensare che devi andare a scuola, che devi andare al lavoro, e anche lì trovarti con le orecchie imbottite di quel verso strisciante e ruffiano.
Non ci vivi, giuro. Non ci convivi con l’anima in pace per più di un mese e mezzo, se sei abituato con le rondini che garriscono o l’usignolo che cinguetta come un pazzo prima dell’alba.
Non ci vivo io e mio papà aveva già oltrepassato e doppiato i limiti di sopportazione dopo la prima settimana.
Ha quindi deciso di prendere quelle soluzioni di cui dicevo.
La prima è stata pacifica.
Ha bloccato l’accesso ai nidi con dei ferri appositi, passando un pomeriggio appollaiato su una chilometrica scala a pioli e armeggiando con fil di ferro e attrezzi.
Soddisfatto del suo operato, la sera è andato a dormire contento.
Il mattino dopo, alle ore sei precise, un gorgoglio tubante lo ha distratto dal sogno e l’ha riportato alla realtà; convinto di essere ancora in un incubo, ha spalancato il balcone ed ha assistito al tranquillo farsi largo dei piccioni tra gli spunzoni. Beati, tranquilli loro: con le ali e un incedere leggermente tronfio e sempre con quel je ne sais quoi di incredibilmente ottuso, passavano attraverso il confine appuntito che papà tanto aveva lavorato per ergere.
Un pomeriggio in alta quota mandato in malora.
Già alla seconda soluzione il pater familias era passato a un che di meno pacifico.
Approfittando del periodo –era quasi Halloween-, ha comprato una scatola di petardi e si è costruito una specie di trincea nel terrazzo, dalla quale spiava i movimenti dei pennuti.
A questo punto dovete immaginare vostro padre che di mattina si sveglia a ore assurde e, in camicia da notte, apre di soppiatto la finestra e lancia fuori un petardo, così.
Poi si incazza, perché i piccioni –che poi si dice stupidi, stupidi… Alla faccia degli stupidi- già al secondo petardo avevano capito che al breve sfrigolio della miccia seguiva l’esplosione.
Quindi loro, placidi e imperturbabili, all’udire il leggero crepitio pre-scoppio, levavano i regali sederi piumati dal nido e se ne andavano sull’albero a godersi i fuochi d’artificio.
Per poi, ovviamente, tornare e commentare con allegri gru-gru quanto divertente fosse stato l’assistere al botto.
Probabilmente avevano pure sparso la voce di questo allegro spettacolo, perché nel giro di una settimana la famiglia di piccioni si è allargata, aprendosi a una nuova e giovane coppia di pennuti.
I quali, da che natura è natura, hanno iniziato immediatamente a sfornare uova e piccoli uccellini.
Puntualmente, al nascere di una nuova generazione pennuta, il conflitto a fuoco si sospendeva, perché i piccoli facevano tenerezza.
Appena mettevano il becco fuori dal nido, però, il capo della resistenza rimetteva mano alle armi.
Era diventato una vera guerra, con tanto di alleanze e spartizione dei ruoli.
Capo comandante generale indiscusso, nonché artificiere e capo dell’attacco aereo era mio papà.
Mio fratello minore l’addetto ai rifornimenti, il fratello mezzano era lo stratega.
E i gatti, i miei amati sei gatti, erano diventati preziosi alleati di terra, con i quali papà contrattava a suon di lische di pesce e scatolette di tonno allo scopo di convincerli a mirabolanti acrobazie per arrampicarsi sulle colonne, entrare nei buchi dove stavano i nidi e fare razzia.
Dopo un paio di mesi e qualche centinaio di petardi lanciati con inutile precisione esattamente dentro i nidi, mio papà si è illuminato ed è passato alla terza tecnica.
Ha rapito un mio amato peluches a forma di pappagallo rosso e blu, l’ha imbragato in una specie di cintura elastica e l’ha posizionato ad ali spiegate esattamente davanti al nido principale dei colombi.
La presenza inquietante, devo dire, ha funzionato.
Per quasi una settimana non siamo stati svegliati dal tubare dei pennuti.
Purtroppo, si sa, il bel gioco dura poco, e gli invasori si sono presto accorti della bufala e sono tornati a vivere nelle loro casette sottotetto, quasi felici di avere un nuovo silenzioso e colorato vicino.
A quel punto stavamo seriamente pensando di cambiare casa.
Un giorno però, mia mamma è stata colta da un’idea mentre puliva la casa.
Ha preso il mocio vileda che da mesi militava nella nostra lavanderia, e con fare atletico l’ha lanciato come un giavellotto diritto nel foro del nido.
Vedendo che i piccioni non tornavano, ha continuato la sua operazione, rendendo il nostro portico alquanto ridicolo; voglio dire, già c’era un pappagallo di peluches appeso al soffitto, aggiungendo a questo una serie di scope di saggina o di stoffa che stavano conficcate sulla cima delle colonne, si arrivava a risultati alquanto allucinanti.
Comunque sia, anche dopo questo tentativo abbiamo avuto un altro periodo di pace.
Il terribile verso gru-gruante non ci assillava più il mattino, rendendoci isterici e irritabili tutta la giornata.
Ma un giorno è tornato.
E non capivamo neanche da dove venisse, porca miseria, c’erano scope conficcate ovunque, i buchi erano tappati, il sottotetto era pieno di piccoli alveari di vespe in quel periodo (la primavera stava ormai arrivando), pareva impossibile; che fosse un’allucinazione?
Ahimè non lo era.
I piccioni, semplicemente, approfittando della nostra gentilezza di aver lor fornito un tale comfort, si erano intrufolati nei fori e fatti il nuovo nido nella parrucca del mocio vileda.
Ovviamente si erano stabiliti nuovamente nella parte più nascosta all’interno della colonna, così da essere ancor meglio protetti e invisibili a qualsiasi offensiva.
Una volta comprati un paraorecchie per membro della famiglia, siamo giunti alla conclusione più spietata, l’unica che non avremmo mai voluto, ma purtroppo l’unica per liberarci dei nemici.
Era ormai quasi un anno che combattevamo inutilmente.
Era quasi un anno che i piccioni si riproducevano ininterrottamente, continuando a prolificare a ritmi insostenibili.
Avevamo capito finalmente il loro unico punto debole.
Una mattina, armati di scopa, i miei genitori sono saliti in terrazzo.
Hanno posizionato le loro lunghe armi dentro i fori, sopra i nidi e, dopo aver fatto fuggire le madri piccione, hanno eliminato il problema alla radice: PATAM!
Un colpo secco e le uova, la generazione di maggio della famiglia piccionesca sono andate in frantumi.
Da allora non sono più tornati, i piccioni.
Sono arrivate le formiche, in compenso, ma questa è un’altra storia.